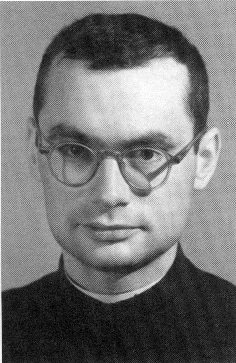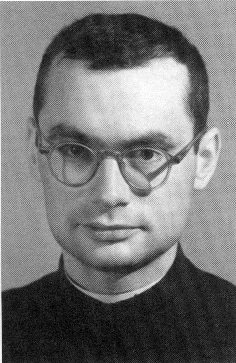PICCOLA BIOGRAFIA DI P. MARIO CASTELLI
ricavata dal Volume
di P.PARISI - P.POLVERARI - P.STANCARI - G.TROTTA - P.TUFARI
""MARIO CASTELLI S.J. / LAICITA’ COME
PROFEZIA""
ed. Rubbettino 1998
IL PERIODO DELL’IMPEGNO SOCIO - POLITICO E ACLISTA
Mario Castelli
nasce da Leone e Diana Manetti il 1 giugno
1919 a Venezia ed è battezzato il mese dopo, il 1 luglio nella Parrocchia di Santo
Stefano. La sua formazione si svolge in un ambiente agnostico religiosamente e non molto
coinvolto nella organizzazione Chiesa, anzi nato su uno sfondo anticlericale, sempre vivo
nella Repubblica Serenissima. In casa circolavano i volumi di Renan e da essi alla
scoperta della Bibbia il passo fu breve. 1924 Mario si ammala gravemente a 5 anni.
forse meningite e la mamma disperata riscopre la devozione alla Madonna e glielo affida e
insieme glielo dona. Lui stesso dimostra una propensione alla ricerca religiosa, anche in
conflitto con i progetti della famiglia. 1931 Studia privatamente disegno
dall’età di 12 anni. La passione per l’arte gli sarebbe restata per sempre,
coma anche quella per la storia e la geografia. Gli resta una ostinazione tenace di
rispondere, nonostante tutto, alla propria domanda religiosa, attraverso canali paralleli,
in parte nascosti e in parte apertamente conflittuali con quelli della normale vita. 1934
i rapporti tra i genitori di M. sono in crisi da tempo, in padre, prima ragioniere e poi
imprenditore, commercia materiale elettrico, ma va in difficoltà notevoli a seguito della
grande "crisi economica" del 1929-1930 e fallisce nel 1933 e domanda l’anno
successivo, di partire per l’Africa, nella guerra d’Etiopia (Eritrea e Somalia
1934-1936: 6/5 Addis Abeba e 9/5 Proclamazione dell’Impero) e là invita anche la
moglie, in grave crisi depressiva. In suo luogo parte Liliana, la sorella di M. e lo
raggiunge a Diredaua. 1941 (26/2) dopo vari rinvii e una ricerca della propria
vocazione con don Alessandro Gottardi (poi vescovo di Trento e ora ritirato a Revine. TR)
che lo voleva nel Seminario diocesano, parte per l’Ordine a Lonigo (Tv) e inizia i
suoi studi: 1942-1945 FILOSOFIA a Gallarate (Mi), 1945-1946 insegna MATEMATICA e GEOGRAFIA
a Roncovero (Mi), 1946-1950 studia TEOLOGIA a Chieri (To). 1949 è ordinato
sacerdote e celebra la sua prima Messa a Santo Stefano (Ve) e a Limena (Pd) e gli
servivano Messa Pino Piva e Toni Melloni, divenuti poi sacerdoti gesuiti.
Dall’ottobre 1950 al maggio 1951 va in Germania nella città di Munster
in Westfalia per il terzo anno di noviziato in preparazione agli ultimi voti. Viene
mandato, come esperimento, a lavorare in una miniera di carbone per due mesi. Poi va in
Francia e studia a Parigi per 2 anni (1952-1953) all’Institut des Sciences
Politiques, quando là si creava il rinnovamento della teologia e della pastorale
sociale (nel 1941 si era aperto a Lisieux il Seminario della "Mission de France"
e nel 1943 era sorta la "Mission de Paris", patrocinata dal Card. Suhard, dopo
la lettera pastorale Essor ou decline de l’Eglise; nel 1943 Daniel e Godin
pubblicano France pays de mission e nel 1946 Le Bras presenta Introduction a la
pratique religeuse en France e si pensa ad un rinnovamento radicale della pastorale
nei luoghi e ambienti di lavoro. Nel luglio 1941 Jacques Loew, avvocato di Nizza si fa
scaricatore e prete operaio a Marsiglia). Quella dei preti-operai rimarrà una esperienza
base e un riferimento essenziale della attività successiva di M. La figura del P.O.
interrogava profondamente la dimensione della laicità della Chiesa e della su presenza
nel mondo contemporaneo. La Francia fu per tutti gli anni cinquanta un riferimento
essenziale per quell’ansia di rinnovamento che attraversava l’inquieto mondo
cattolico; lo fu anche per M. e ne avrebbe segnato tutta l’esperienza successiva.
- 1953-1967
lavoro di M. ad AGGIORNAMENTI SOCIALI a San Fedele a Milano, dove
il Card. Schuster aveva chiamato i Gesuiti a fondare un centro studi culturali e sociali.
La rivista era stata ideata nel dopoguerra ed era nata nel gennaio del 1945, nel Convegno
all’Istituto Aloisianum di Gallarate. Poi padre Giacomo Perico continuò la
preparazione trasferendosi a Milano e la fece uscire nel 1950, diretta insieme a p. Toldo
e p. Rosa e con la spinta di p. Pietro Costa, l’allora Provinciale. La rivista era
"destinata a quanti, sacerdoti e laici, lavoravano nel campo sociale, allo scopo di
aggiornarli mensilmente, mettendo loro a disposizione quanto di meglio e di più
interessante per la loro cultura e attività era apparso nella stampa, integrando questa
documentazione con opportuni inquadramenti, valutazioni, precisazioni, rilievi"
(Aggiornamenti sociali n. 1 del 1950 pag. 11). M. giunge alla rivista nel 1953 con p.
Mario Reina. Gli anni cinquanta sono anni duri, dove lo spettro del Comunismo inquieta gli
ultimi anni di Pio XII, in drammatico declino, la difesa della "civiltà
cristiana" produce una chiusura aspra e insieme fragile. Nel 1951 a don Mazzolari è
proibito di pubblicare "Adesso", va in crisi l’Azione Cattolica con
la presidenza Gedda e le dimissioni di Arturo Paoli, Carlo Carretto e Mario Rossi. Nel
1952 viene sospeso a divinis don Zeno Saltini di "Nomadelfia". Con D. M.
Turoldo tutti questi sono personaggi a cui M. "era molto legato", dice la
cugina Milly.
- 1953
il 23 settembre il Card. Marella dichiara ufficialmente finita
l’"esperienza" dei Preti operai francesi, che si dichiara chiusa 1 marzo
1954, con reazioni forti e conflittuali. Poi nel 1959 con un decreto del Santo
Ufficio venne cancellato ciò che rimaneva dell’esperienza dei P.O. e ciò "fu
per lui un grande dolore", ricorda la cugina Milly. In Italia dopo la crisi del
centrismo della DC del 1953, il Vaticano si oppone a qualsiasi apertura a sinistra. Aggiornamenti
sociali vive una difficile situazione: il dibattito a Milano è molto vivace,
l’intervento di Carlo Colombo ha aperto un confronto alto sulle nuove prospettive
politiche di una DC in calo di voti. Si assiste al crescere di una forte dialettica tra le
varie posizioni, poi correnti. Alla rivista si cerca di valutare criticamente i veti
ecclesiastici, "giudicandoli più come esortazioni, che come ordini". Nasce nel
convegno di BELGIRATE (23 settembre) la corrente "La Base" della sinistra
democristiana (Marcora, Galloni, Granelli, Chiarante. Scrive il documento fondativo
Lazzati). Nel 1954 arriva a Milano il Card. Montini. San Fedele si trova in una zona di
frontiera: "Padre Castelli ha vissuto tutto l’entusiasmo di un’opera che si
stava formando e tutte le difficoltà di trovare una linea nuova e originale con i
fratelli altrettanto decisi e motivati, ma ciascuno dei quali aveva proprie idee. Credo
che abbia avuto parecchie difficoltà à " (Salvini).
- 1955
La "Base" vince il Congresso provinciale della DC di Milano, mentre a
livello nazionale si fanno più forti le spinte per l’ apertura di una nuova stagione
politica. I casi critici di Venezia e di Firenze, evidenziano una situazione di
transizione che diventa in alcuni momenti drammatica. Proprio padre Toldo della rivista,
fu inviato a VE per una indagine riservata. Il Cardinale Roncalli era
"costretto" a condannare "la pertinacia di coloro che sostenevano ad ogni
costo la cosiddetta "apertura a sinistra". Il settimanale "Il
popolo veneto", diretto da Dorigo, sospendeva le pubblicazioni e il suo direttore
non era eletto al Congresso DC di Trento. A.S. si era trovata al centro della
bufera, anche se in modo discreto. Nel 1957 il cardinal Roncalli mandava un
messaggio augurale ai delegati socialisti, che celebravano a VE il loro Congresso.
"Con quel gesto, che seminava scompiglio negli ambienti di Curia, il Cardinale
intendeva camcellare il ricordo della Lettera dell’agosto 1956 e rendere
palese il suo dissenso con la politica di Pio XII: era la prima seria manifestazione, che
la separazione esistente da tempo nel mondo cattolico, aveva ormai guadagnato anche le
gerarchie ecclesiastiche. Di qui la pronta e netta reazione della Curia, che non esitò a
sconfessare praticamente il presule veneziano" (Settembrini). Sono questi gli anni di
una crisi anche nella redazione di A.S. L’abbandono di padre Toldo, provocò
un ripensamento di tutto il gruppo dirigente. Il provinciale di allora nominò Castelli
direttore. In seguito il gruppo andò rafforzandosi. E’ la prima generazione di
Gesuiti, che aveva prevalentemente studiato in Francia, vivace e libera nelle sue scelte,
perché non c’era nulla con cui confrontarsi, molto decisa nella difesa dei
sindacati, delle ACLI e dei lavoratori (Salvini). Dice padre Reina, arrivato con M.
"...si lavorava, qualche volta si litigava. Castelli era esigente. Ricordo che una
volta padre Rosa, sotto Natale, doveva preparare un articolo. Dissi a Castelli, che in
quel periodo non poteva dedicargli molto tempo. Mi rispose deciso: "per noi è Natale
tutti i giorni!". "Fino al Concilio -scrive padre Sorge- A.S. è
considerata una rivista ‘di punta’ dei Gesuiti e della Chiesa italiana",
una rivista di frontiera. "Aveva avviato con la società milanese e nazionale un
serrato dialogo, riflette Ada Ferrari. Messa da parte la fretta di vincere, legata a forme
di revanchismo cattolico che i gesuiti di San Fedele ripudiavano, ci si concentrava sullo
sforzo di individuare, quale potesse essere l’apporto cattolico alla edificazione
della nuova società. Si precisava dunque una percezione della verità, anche come
costruzione sociale, che pareva la modalità intellettuale meglio atta ad esprimere il
messaggio cristiano in una società di massa. ...non si trattava di dimostrare la
compatibilità del cristianesimo con la democrazia, ma di mettere a nudo, attraverso una
pratica intellettuale rigidamente aliena da coperture retoriche, l’intrinseca
dimensione democratica del Cristianesimo. Ma questa democrazia non era astratta proiezione
ideale, ma realtà ben concreta analizzata con un realismo che ripudiava ogni nostalgico
disdegno per la nozione stessa di società di massa... Non c’è dubbio, a giudizio
dei Gesuiti, che si dovesse lavorare per ‘l’istaurazione di un nuovo ordine
economico e sociale’, si trattava di ‘piegare lo sviluppo produttivo al bene
globale della società. Non era mistero che vedesse con favore una futura collaborazione
con il socialismo, al cui travaglio interno guardava con interesse e rispetto"
(Annali della Fondazione "Pastore").
- 1958
Muore Pio XII il 9 ottobre e la Chiesa cattolica è in un momento difficile. Si
pensa a un periodo di transizione e si nomina Giovanni XXIII il 28 ottobre (+3 giugno
1963) e si diffondono le prime notizie circa un imminente Concilio. Ma "erano anni
turbolenti - ricorda padre Bonato - In quelli anni la rivista era revisionata dalla Curia
milanese. Io leggevo i suoi articoli, che illuminavano il rapporto profondo tra fede e
politica. Un tema che non è mai stato approfondito. Egli metteva in risalto cosa era la
Chiesa nel mondo, cosa un laico o un politico credente doveva fare. ...Le difficoltà con
Montini riguardavano le caute aperture al centrosinistra. Allora Aggiornamenti sociali
faceva notizia, il suo peso era molto forte. Quello che succedeva ad A.S. era
sentito anche a livello nazionale come un campanello di allarme". Prende avvio il
CONCILIO VATICANO II (I annuncio 25 gennaio 1959/ apertura 11 ottobre 1962): le energie
prime represse, ora finalmente si liberano: riforma della Chiesa e ripensamento profondo
del rapporto tra la fede e la storia. Finisce il sogno di una "nuova
cristianità", si aprono i problemi immensi di una nuova evangelizzazione, in un
mondo non più cristiano. "Padre Castelli era una spanna più avanti degli altri. Ha
sofferto molto, ma sapeva capire anche chi non capiva. ...In un incontro di allora
Lazzati, allora rettore della Università cattolica, diceva: ‘Da laico devo
riconoscere che fate un lavoro bellissimo, ma vi manca qualcosa, la profezia’ "
(Bonato). Il rapporto Lazzati -Castelli è un altro dei capitoli della sua biografia, che
andrebbe approfondito.
- 1962
Importanti elezioni amministrative e alla vigilia M. scrive: "in
questa situazione , affermare o accreditare l’opinione, che ogni atto che comporta
rinnovamenti anche profondi dell’attuale sistema economico e sociale del paese
rappresenti un ‘cedimento’ alle istanze socialiste , manifesta una concezione
statica e conservatrice del messaggio cristiano, che lo svuota di contenuto ed efficacia e
comporta una rinuncia a svolgere una funzione determinante nel processo di rinnovamento
della società italiana" ("Elezioni e nazionalizzazione" in A.S. n.
7-8 del luglio agosto 1962).
- 1965
La direzione di padre Castelli è contrassegnata da questo clima di lavoro
intenso, ma anche dalla preoccupazione di tenere coeso il gruppo e di affiatarlo.
"Castelli ci teneva agli incontri di gruppo fuori Milano per la sua coesione. Fu un
periodo di grande slancio della rivista. Ci furono episodi di tensione, come la polemica
di Montini. Riconoscevo in lui un carisma, un modo di vedere la vita religiosa in rapporto
con il mondo molto forte, molto spirituale: Trovo significativi due articoli, uno sui
poveri (A.S.10/’55) e l’altro su l’opinione pubblica nella Chiesa (A.S.
1/’59). Ricordo anche il suo viaggio in Russia, che gli è costato all’epoca una
reprimenda sull’ "Avvenire d’Italia" ...Altra cosa
significativa alla quale teneva molto, era il rapporto con La Pira. Su A.S.
(n.2/’65 e 3/’65) ha voluto pubblicare lo scambio di lettere tra La Pira e
Kruscev. Questo denota il suo coraggio , il suo modo di vedere la politica, come opera di
Dio. Si deve leggere in proposito anche il necrologio che ha fatto su A.S.
(n.12/’77) per Giorgio La Pira" (Reina). Questo ci richiama la sensibilità e le
prospettive politiche e culturali di M.: l’apertura a sinistra, che valutava
positivamente, doveva coincidere con un originale progetto riformatore e con un
ripensamento profondo del ruolo dei cristiani nella politica e nella società. La
democrazia può essere incarnata da ragioni cristiane, ma ciò implicava per M. non
solo forme politiche e istituzionali nuove, ma anche una diversa politica economica. Per
questo non basta il richiamo alla dottrina sociale della Chiesa, troppo generica in vista
di un piano concreto di azione sociale e politica da attuare oggi. Alla fine del 1965
il nuovo Padre Generale Pietro Arrupe, eletto il 22 maggio, aveva avviato una ricerca
sullo stato dell’Ordine per adattare la sua attività apostolica alle esigenze dei
nuovi tempi. La direzione della ricerca per l’Italia era stata assunta dal Igino
Ganzi. Il gruppo di A.S. è coinvolto in prima persona , a partire dal direttore e
M. responsabile del gruppo "studi sociali" stenderà le conclusioni
dell’importante seminario, che si era tenuto a Villa Cavalletti dal 4 al 9 luglio 1966.
Si trattava di proposte di scelte coraggiose, che comportavano un ridisegno
organizzativo e pastorale della presenza della campagnia in Italia: la provincia italiana
doveva attrezzarsi ad essere strumento di una nuova organizzazione. "L’impegno
di padre Castelli sia nelle riunioni preparatorie, che nella stesura del documento finale
forse non passò inosservato a padre Arrupe. Proprio Castelli poteva essere l’uomo
adatto ad affrontare l’impresa...".
- 1967
Si può dire che negli ultimi anni in cui M. ha diretto la rivista,
questa ebbe momenti di contrasto molto forti, come emerge dalla lettura dei verbali di
redazione. Padre Macchi e Padre Rosa erano su posizioni assai diverse da quelle di lui.
"Solo quando verrà fatta una storia di A.S. si potrà avere con esattezza la
misura dell’importanza e dell’originalità di questa esperienza milanese della
vita di Castelli". "La fine di questa esperienza gli costò moltissimo",
ricorda la cugina Milly. Uno degli ultimi impegni del suo periodo milanese fu il dibattito
"discreto" aperto con la Confindustria sui temi cruciali della programmazione. A.S.
del settembre-ottobre n.7-8 1967 cambia il suo direttore (M. era stato direttore
dal novembre 1957 e membro della redazione dal novembre 1953). Castelli lascia
l’incarico per assumere l’incarico di superiore provinciale della Provincia
Lombardo-Veneta della Compagnia di Gesù e riaffermava: "La rivista aveva mirato
soprattutto ‘all’osservazione dei fatti, li aveva sempre accostati nella loro
nuda realtà, anche se portavano argomenti a sostegno di tesi non condivise
dall’intero corpo redazionale’." Ma oltre ai fatti c’era la loro
interpretazione. La rivista aveva cercato di coglierli ‘dinamicamente; nel
giudizio sugli avvenimenti dell’oggi si è sforzata di scorgere i germi della
evoluzione futura’. Non era mai stata un bollettino ufficiale delle posizioni
politiche e sociali ecclesiastiche. Chi leggeva A.S. voleva ‘sapere non
già che cosa pensino le istanze sociali del mondo cattolico, ma che cosa possa un
cattolico... ragionevolmente pensare degli avvenimenti e delle questioni che interessano
la società moderna’ . Era l’eredità che egli lasciava alla generazione che
sarebbe venuta, una eredità fatta di dignità, di studio, soprattutto di libertà.
- 1967-1975
Al governo della Compagnia di Gesù. Diventa Provinciale della provincia
Lombardo Veneta. Risiede prima a Verona, poi dal 1968 a Milano. Egli "era una persona
che credeva a quello che diceva e , mi pare suscitando un grosso consenso, cosa non sempre
facile negli ordini religiosi. E’ stato padre Provinciale, ma, secondo me, troppo
poco. In questa carica lasciò grandi consensi... (Salvini). Il rapporto Tra M. e
padre Arrupe è un altro dei capitoli di questa storia che andrebbe approfondito.
L’esperienza della Compagnia in questi anni presenta una drammatica ricchezza. La
centralità del tema della povertà, l’urgenza di mettersi al servizio dei
diseredati, tentativo di ritrovare lo spirito delle origini mettono in crisi la
tradizionale immagine dell’Ordine, inaugurando esperienze, che per la Santa Sede sono
inquietanti... All’interno stesso della Compagnia nasce un movimento di opposizione.
Padre Arrupe è sotto accusa e lo porteranno nel 1980 a dimettersi. Diceva: "E’
per questa via indivisa e ardua che la Chiesa pellegrina deve faticosamente procedere. Fede
e giustizia sono indivise nel Vangelo, il quale insegna che la fede opera per mezzo
della carità, perciò non possono essere separate nei nostri programmi, nella nostra
azione, nella nostra vita. Questo è ciò che la nostra Congregazione intende per scelta
decisiva. E’ la scelta che sottende e precisa tutte le altre contenute nelle sue
dichiarazioni e direttive". Nel 1970 M. venne destinato ad un incarico,
la riunificazione delle Provincie, apparentemente più alto, ma più scabroso. "Di
questo la sua popolarità e la sua pace spirituale ne hanno molto risentito"
(Salvini). Egli è uno dei più convinti interpreti dell’azione di rinnovamento di
Arrupe e contro di lui si manifestano i dissensi di un organismo attraversato da profonde
contraddizioni. Le resistenze, le polemiche, le incomprensioni dolorose riguardano il
senso della Compagnia, dell’essere Gesuiti in una società secolarizzata, densa di
domande e di nuovi problemi. Il primato della Parola, l’amore geloso per i poveri,
l’urgenza della povertà come modo di essere non solo dei singoli, ma della Compagnia
esigono scelte coraggiose, che per molti sono difficili, per alcuni incomprensibili, per
altri semplicemente sbagliate. (Cfr. Proposta del "lavoro manuale" per i gesuiti
nel documento del dicembre 1973, in preparazione della XXXII Congregazione generale
dell’Ordine). "Padre Mario aveva anche i suoi limiti, i limiti di quei
caratteri molto intelligenti, anticipatori, che un po' pestano i piedi. Non era molto
paziente, era un uomo di governo, non molto pacifico e sereno, perché vedeva le cose e
non riusciva a persuadersi di certi comportamenti. Non sempre aveva la pazienza di saper
sopportare la piccolezza dei suoi sottoposti. A volte c’erano dei contrasti, proprio
perché era troppo intelligente e di temperamento forte. Non capiva che ci potevano essere
difficoltà di tipo psicologico. Lui era quello che stimolava. Ma trascinare gli altri non
sempre è facile" (Ganzi). C’é nel Castelli di questi anni una urgenza di
rinnovamento, un’ansia ecclesiale, che deve tradursi anche in scelte coraggiose,
visibili, di testimonianza. Un gesuita dirà allora alla sorella di M.: "La
rovina dei gesuiti, ha fatto chiudere il collegio, pensa ai preti-operai, è un
disastro" (Liliana).
- 1975-1981
a Parma. "E’ l’anno in cui, terminato lo speciale incarico
affidatomi da padre Arrupe (unificare istituzionalmente la direzione dell’attività
apostolica dei Gesuiti in Italia), ho lasciato Roma". La nuova destinazione è Parma.
Pino Piva parla di un "confinamento", di un "isolamento" di
M. nella città emiliana, dopo la contrastata esperienza di "delegato".
Qui comunque, è possibile seguire da vicino una esperienza di confine. "Dapprima il
Centro giovanile, poi tutta la casa si apre a ogni sorta di bisognosi: giovani del
riformatorio, ex-carcerati, studenti soprattutto stranieri, prima arabi, poi greci e ora
africani; più recentemente i tossicomani, senza che vengano meno i precedenti clienti...
Su questi due strati precedenti, nell’ottobre del 1975 è stato immesso il
gruppo di gesuiti-operai. E’ stata una specie di rifondazione per tutta la comunità,
in quanto questa presenza induce le attività che già si facevano ad acquisire un nuovo e
più preciso significato globale: tutta la comunità, chiesa, Centro giovanile e azione
esterna vengono impostati in modo da contribuire alla pastorale per i non credenti".
(Cfr. "Esperienze di una comunità di Gesuiti" in Aggionamenti sociali di
luglio agosto 1980). Dopo il Concilio l’esperienza dei P.O. riprende, infatti al cap.
8 della "Presbyterorum ordinis" si afferma: "Tutti i Presbiteri hanno la
missione di contribuire ad una medesima opera, sia che esercitino il ministero
parrocchiale o sopraparrocchiale, sia che si dedichino alla ricerca dottrinale o
all’insegnamento, sia che esercitino un mestiere manuale, condividendo le condizioni
di vita degli operai -nel caso che ciò risulti conveniente e riceva l’approvazione
dell’Autorità competente- sia infine che svolgano altre opere d’apostolato o
ordinate all’apostolato". (Enchiridium Vaticanum n. 1267). Tuttavia il gruppo
stenta a darsi un coordinamento nazionale e a inserirsi stabilmente nella vita ecclesiale.
Negli anni del suo governo della Provincia italiana della Compagnia M. aveva
favorito la ripresa dell’esperienza, l’aveva sostenuta. Ora vi entrava, come
dire, personalmente nel merito. "Ha accettato di essere il parafulmine e il
traino di questa esperienza operaia, perché ci credeva. Noi spesso lo abbiamo utilizzato
come parafulmine. La su personalità ci ha aiutato a sfondare ad essere accettati dentro
la Compagnia" (Pino Piva). "...Verso la nostra esperienza di preti-operai
c’erano delle resistenze, delle incomprensioni " (Toni Melloni). Insieme al
nucleo dei gesuiti-operai c’è il Centro giovanile, aperto a ogni sorta di bisognosi,
specialmente giovani. Esso è gestito da tre Gesuiti: uno si occupa dei tossicomani; un
altro degli studenti stranieri, degli obiettori di coscienza, delle scuole popolari; il
terzo di poveri da vestire e rifocillare. L’esperienza della comunità fu seguita da M.
in modo profondo. Egli cercò di coglierne sempre i limiti e le opportunità, di porla
sempre di fronte alle sue domande di fondo. La lunga lotta degli obiettori, ad esempio, fu
da lui seguita con attenzione vivissima. Alessandro Trevisan, ora gesuita della comunità
di padre Pino Stancari (coautore del libro) a Cosenza, presentò domanda di obiezione e fu
da lui appoggiato e seguito durante tutto il lungo processo a cui fu sottoposto. Nasce
dall’esperienza parmense tutta la sua riflessione sulla "laicità della fede",
come profezia sulla storia. Egli parlerà di una "riemersione, nella sfera della
coscienza, dei sedimenti di cultura biblica, giudaica, cristiana assorbiti da Marx nella
sua infanzia e adolescenza..." e proporrà di "attraversare l’esperienza
operaia appropriandosi della originarietà delle proprie parole. Quei sedimenti di cultura
biblica, giudaica, cristiana, che alludono ad un ribaltamento di prospettiva, che andrà
chiarendosi nella successiva riflessione. Questi sono anni di maturazione e di
trasformazione. Una delle novità dello stile della sua direzione spirituale della
comunità è questa traversalità delle esperienze, far coesistere insieme iniziative
diverse, perché si integrino, perché generino comunicazione ecclesiale. In questa ottica
promuove la Consulta diocesana del lavoro. "Il fine, diceva, è il favorire la
modifica dell’ambiente ecclesiale in modo che l’operaio, specialmente il
militante, possa trovarsi in esso a suo agio". Poi arriva quello che Pino Piva
definisce una "ulteriore conversione"
quando M. "ha preso in mano la Bibbia, ha cominciato a studiarla, ad
approfondirla, a pregarci sopra e tutto il resto è passato in secondo piano... aveva
iniziato anche dei pellegrinaggi": Pentecoste 1978 e nella Quaresima del 1979.
E’ il momento di una riflessione, che segna il distacco e l’avvio della
"prova".
1981-1997 già dall’anno precedente il morbo di Parkinson ha iniziato il suo
lavoro di demolizione nel fisico e nello spirito di M.. "Si è accorto della
malattia -ricorda la sorella Liliana- nel novembre 1980. Era sconfortato, perché
lo zio, fratello della mamma, è morto di Parkinson, quando lui era a Milano, e andava
tutte le sere a trovarlo... lo ha seguito fino all’ultimo respiro". Nel 1982-’83
si aggiunge il fuoco di Sant’Antonio, che "lo ha distrutto... gli aveva
intaccato il sistema nervoso" (Liliana). "Soffriva tremendamente. C’erano
difficoltà anche psicologiche legate alla depressione" (Parisi). Sono anni di
sofferenza e la malattia impedisce sempre più l’attività. Muore il 10 maggio
1997.