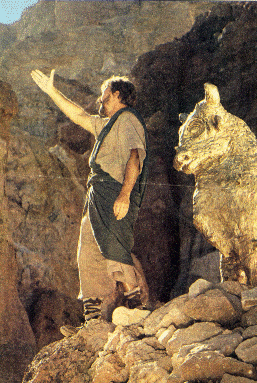 |
La prima città che compare nella Bibbia è Enoch, la città edificata da Caino e da lui chiamata col nome del figlio: essa rappresenta una sorta di rifugio per Caino stesso e per i suoi discendenti; e l'atto di dare il nome costituisce, secondo la mentalità biblica, una presa o una rivendicazione di possesso di qualcosa su cui si intende affermare un diritto.
La città di Enoch, costruita per Enoch, è città organizzativamente perfetta: consta di tribù che lavorano nei campi, attendono al bestiame, lavorano i metalli, promuovono momenti di sollievo comune e anche provvedono ai desideri inconfessabili dell'umanità. Gen 4 mostra l'evolversi di questa organizzazione fino al momento in cui viene avvertita l'esigenza di una legge comune. Questa non avrà di mira la necessità di difendere il diritto del giusto anche quando è più debole, ma, all'opposto, rimetterà l'ultima parola al più forte, cioè a chi possiede una capacità più estesa di vendetta:
Lamech disse alle mogli:
"Ada e Zilla, ascoltate la mia voce;
mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire:
Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura
un ragazzo per un mio livido.
Sette volte sarà vendicato Caino
Ma Lamech settantasette (Gen 4, 23-24).
Il fondamento della legge di questa città è l'esistenza dell'odio, ed è per difendersi da esso od offendere con esso che esistono la città stessa e la sua legge. Enoch non presuppone, cioè, il pentimento per il male fatto con l'uccisione di Abele, ma solo l'autodifesa della stirpe dell'uccisore. In essa non è necessario amarsi: la sua legge è, anzi, l'estraneità, l'indifferenza, la vendetta.
Ma dirimpetto al gruppo dominante di Enoch, Gen 4, 26 pone un altro gruppo, quello di coloro da parte dei quali "si cominciò a invocare il nome di JHWH "; coloro cioè che, a partire da Enos, si riuniscono per iniziare il culto pubblico di JHWH, il Dio che è amore, assicurandone la presenza nella città stessa di Caino covo di vendetta. All'organizzazione della città di Enoch lo Spirito non contrappone un'altra città, ma uno "stato di persone", un germe di vita eterna, di amore, immesso nell'unica città costruita dall'uomo. Non due città, dunque, ma la città di Caino in cui domina una legge di violenza alla quale e nella quale viene opposta una legge di preghiera: un "chiamare Dio per nome", un trattare Dio nella sua intimità, l'assicurargli un culto. Grazie a questa forza spirituale intima, di cui il Nuovo Testamento, all'ultimo, è rivelazione, la città di Caino diventerà città salvata, Gerusalemme santa, diventerà Regno Eterno.
La città di Dio non viene, come si è visto, scoperta subito, rivelata immediatamente, ma è frutto di un lento processo: non un'evoluzione inoffensiva, bensì una lotta mortale dentro la città di Caino e per la salvezza di essa; una lotta che
ha per protagonista l'uomo, per obiettivo la "riappropriazione" della città da parte sua, per suo modello operativo Cristo, e per esito la Celeste Gerusalemme che non è però conquista umana, ma è destinata a discendere dal cielo come dono di Dio agli uomini affinché siano in essa una cosa sola con Lui.
Quale figura abbia questa città donata da Dio agli uomini può vedersi in controluce dagli aspetti negativi via via sottolineati dalla Bibbia nel presentarci altre città.
Abbiamo già incontrato il fattore violenza. E’ a causa di tale violenza che Dio si pente di aver creato l'uomo (Gen 6, 6). Ma anche i figli di Noè, che pure sono stati spettatori della collera divina contro la violenza degli uomini vogliono costruirsi una città "per farsi un nome " (Gen 11, 4) più o meno come Caino (4, 17).
Se la città di Caino già era organizzata secondo categorie ben definite, ora queste categorie sono aumentate e cambiate: uso del mattone, del bitume, irrigazione per mezzo di ben calcolate inondazioni... Babele dovrà tenere conto di questa più complessa articolazione, in vista di un suo armonico ordinamento. L'accento cade sull'organizzazione materiale e sull'efficienza umana necessaria a produrla. Dio non è negato, ma si assiste al tentativo di catturarlo e porlo al servizio di bisogni, interessi, prospettive della società umana, dei quali la città è espressione. Babele è precisamente espressione di una volontà umana ("far si un nome ") da attuare, contro la volontà di Dio mediante la concentrazione dei popoli. Enoch ricercava una difesa da se stessa, da Dio, dai fratelli, proponendo una convivenza ordinata e senza amore; Babele si propone una universalità che, nonostante le diverse destinazioni, è condannata a pietrificare l'unità, e malgrado l'unità è destinata alla dispersione.
All'inizio del cap. 12 della Genesi, dopo la catastrofe di Babele, troviamo Dio che si presenta ad Abramo come Colui che solo può dare il "nome", e che domanda all'uomo completo affidamento: Abramo è richiesto di uscire radicalmente dalle sue origini per diventare il nuovo padre di popoli nuovi che Dio. vuol costituire in comunità umana universale (Gen 12, 3: "in te si diranno benedette / tutte le famiglie della terza "). Cominciamo ad intravedere come Dio operi attraverso quel suo gruppo di fedeli che "conosce il nome di JHWH ", sia sostenendo l'azione, sia comandando l'inazione.
Dalla contemplazione di Enos nasce la comunità dei fratelli, la dispersione come conquista di tutta la terra da parte dell'uomo e come incontro di fratelli nessuno escluso. Sorge cosi l'immagine del Dio vero nella legge vera, quale si formula nel comandamento nuovo di Cristo: Dio non è asservito da nessuno, non sarà mai riducibile a idolo; tutti gli uomini sono orientati verso un solo Dio e un solo Dio raccoglie nella sua unità tutti gli uomini.
Una terza grande città che incontriamo nel racconto biblico è Sodoma. Complessi sono i suoi rapporti con Abramo (con la stirpe di Enos) e con Dio. C'è anzitutto un rapporto di giustizia, variamente definito nella Bibbia: " tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra -, era come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto... Ora gli uomini di Sodoma erano perversi e peccavano molto contro il Signore" (Gen 13, 10-12); "Ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sodoma: essa e le sue figlie avevano superbia, ingordigia, ozio indolente, ma non stesero la mano al povero e all'indigente; io le vidi e le eliminai" (Ez 16, 49-50). E contro Sodoma Dio manda i suoi angeli.
Ma anche in questo caso Dio manifesta un altro volto, quello della sua misericordia, con la quale Egli vuole rispondere al peccato nella comunità che sarà dei suoi santi. La rivelazione e l'esaltazione di questo secondo volto di Dio avviene nel famoso dialogo tra Dio e Abramo sul destino di Sodoma (Gen 18, 22-33). Non è un santo litigio tra un Dio custode della legge e la misericordia di Abramo, bensì la manifestazione dell'amore invincibile di Dio per l'uomo e per la società umana organicamente intesa. Dieci è il numero minimo necessario affinché si abbia un'assemblea, una comunità ebraica ordinaria: e Abramo arriva ad ottenere da Dio la salvezza per questo "dieci". Il comportamento degli angeli con Lot, e poi la resurrezione promessa a Sodoma insieme ad altre città quale si trova in Ezechiele 16, 55, manifestano l'ampiezza della misericordia.
Anche gli esempi neotestamentari non variano questa grammatica.- La città di Naim è città